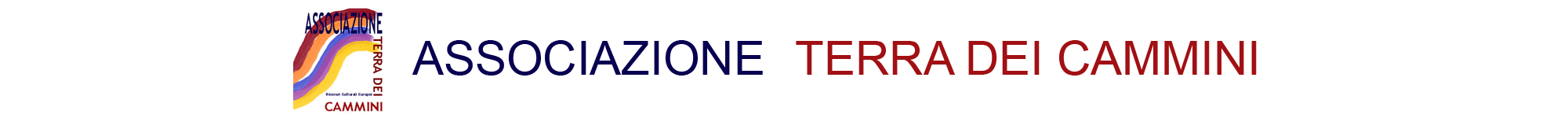3. Il Cammino dei Castelli medievali
Il Cammino dei Castelli in questo territorio ha una motivazione particolare. Esso serve a chi lo percorre a comprendere l’organizzazione benedettina e il rapporto soprattutto tra gli Abati e i signori longobardi che hanno lungamente governato il territorio. È interessante conoscere a mezzo del Cammino, l’evoluzione storica delle strutture che i Monaci dell’Abbazia si sono dati per coltivare il territorio ottenuto in dote dal duca di Benevento, Gisulfo II, nel 744. Per coltivare il territorio i Monaci crearono, infatti, le “Cellae”, chiese minori con annessi terreni che venivano lavorati dai monaci e da dipendenti che avevano l’obbligo di prestare un certo numero di ore di lavoro all’anno. Ogni Cellae rappresentava una “Curtis” che puntava a una crescente autonomia. Dopo il ritorno dei monaci a Montecassino, nel 949, dopo il terremoto e l’espulsione dei Normanni, avvenne l’opera di “incastellamento nella Terra di San Benedetto”. La signoria benedettina si riorganizzò sulla base del Castrum, un tipo di insediamento fortificato e accentrato con aree, a destinazione agricola, disposte concentricamente nello spazio circostante. Il raggruppamento dei coloni all’interno delle mura di fortificazione e la concessione ad ogni colono di parcelle di terreno consentirono un ripopolamento per “castra”. L’opera fu portata avanti con molta determinazione ed efficacia dall’ abate Aligerno (948-985) che seguì in modo particolare la fortificazione di quelle strutture trasformandole così in castelli, grazie alla concessione ottenuta, nel 967, dall’imperatore Ottone e dal principe di Capua e Benevento Pandolfo I Capodiferro. In quell’epoca furono costruiti molti castelli. Oggi restano ancora alcune testimonianze, quelle che sono sopravvissuti alle guerre locali, al loro abbandono, ma soprattutto ai bombardamenti degli Alleati avvenuti durante le battaglie di Montecassino nell’ultima Guerra mondiale.
Il Cammino che porta a visitare queste testimonianze serve a recuperare soprattutto la storia dei luoghi e l’opera di gestione del territorio da parte dei Benedettini, a cavallo degli anni Mille.
Il Cammino che porta a visitare queste testimonianze serve a recuperare soprattutto la storia dei luoghi e l’opera di gestione del territorio da parte dei Benedettini, a cavallo degli anni Mille.
1. Tappa: Terelle - Colle San Magno
Il Cammino tra Terelle e Colle San Magno è stato certamente usato nell’antichità quando nella valle c’erano zone paludose e pericolose. Poi il percorso è stato utilizzato dai Tedeschi per rifornire le linee difensive della Gustav e per portare nelle retrovie i feriti. Oggi è uno splendido modo per fare trekking e visitare due bellissimi borghi medievali.
1.a Il Castello medievale di Terelle
La Rocca medievale di Terelle, meglio oggi conosciuta come Castello di Terelle, fu costruita fra il 1117 e il 1127 dai Conti longobardi di Aquino, Lando e suo figlio Pandolfo, per poter compiere scorrerie sui possedimenti dell’Abbazia di Montecassino. Il duca Boncompagni-Ludovisi nel 1583 lo vendette al re Ferdinando IV di Borbone, con Aquino, Arce, Roccadarce, Santopadre, Roccasecca, Colle S. Magno e Palazzolo (Castrocielo). Fu confiscato nel 1812 dai francesi e concesso alla facoltosa famiglia Iannarelli di Belmonte (Castello) vittima dei soprusi briganteschi contro i francesi di quell’epoca. Qualche decennio più tardi divenne proprietà della famiglia Biondi di Terelle che lo ha ancora.
1.b. Il borgo medievale di Colle San Magno
Colle San Magno venne fondata nel XI secolo quando un gruppo di abitanti di Castrum Coeli” un castello costruito sulla sommità del monte Asprano furono costretti a lasciarlo per le condizioni climatiche. Anche questa cittadina fu oggetto di contesa tra gli Aquino e l’Abbazia di Montecassino. Successivamente però ci mise le mani l’Abate Masone di Montecassino che fece erigere le imponenti fortificazioni sul monte Asprano. La posizione dei presidi militari era altamente strategica per i Benedettini perché erano posti a guardia dei varchi di accesso alla Val di Comino che era la zona più fertile dei domini dell’Abbazia. Per questo motivo risulta interessante la sua storia nella cornice dell’organizzazione territoriale benedettina. Il suo nome deriva dal nome del martire e santo Magno di Anagni. Il centro storico è per lo più medievale, circondato da mura imponenti volute dai signori di Aquino, e si sviluppa intorno alla torre dell’antico palazzo, edificata nel XIII secolo e ristrutturata dopo il terremoto del 1984.
Se venite a Colle san Magno il lunedì di Pasqua potete unirvi ai fedeli che salgono sul Monte Asprano e raggiungono la chiesetta dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo, un santuario mariano costruito nel 1300. Qui i cittadini di Colle San Magno si incontrano con i fedeli che arrivano da Castrocielo e tutti assieme assistono al famoso “bacio delle due Madonne” che ciascun gruppo porta con sé .
Sulla stessa sommità, a 750 metri, di altezza, si possono visitare i resti del Castello di Castrum Coeli che fu il primo rifugio che gli abitanti di Castrocielo trovarono per sfuggire alle scorrerie dei Longobardi, dei Saraceni e dei Normanni, nella valle.
1.a Il Castello medievale di Terelle
La Rocca medievale di Terelle, meglio oggi conosciuta come Castello di Terelle, fu costruita fra il 1117 e il 1127 dai Conti longobardi di Aquino, Lando e suo figlio Pandolfo, per poter compiere scorrerie sui possedimenti dell’Abbazia di Montecassino. Il duca Boncompagni-Ludovisi nel 1583 lo vendette al re Ferdinando IV di Borbone, con Aquino, Arce, Roccadarce, Santopadre, Roccasecca, Colle S. Magno e Palazzolo (Castrocielo). Fu confiscato nel 1812 dai francesi e concesso alla facoltosa famiglia Iannarelli di Belmonte (Castello) vittima dei soprusi briganteschi contro i francesi di quell’epoca. Qualche decennio più tardi divenne proprietà della famiglia Biondi di Terelle che lo ha ancora.
1.b. Il borgo medievale di Colle San Magno
Colle San Magno venne fondata nel XI secolo quando un gruppo di abitanti di Castrum Coeli” un castello costruito sulla sommità del monte Asprano furono costretti a lasciarlo per le condizioni climatiche. Anche questa cittadina fu oggetto di contesa tra gli Aquino e l’Abbazia di Montecassino. Successivamente però ci mise le mani l’Abate Masone di Montecassino che fece erigere le imponenti fortificazioni sul monte Asprano. La posizione dei presidi militari era altamente strategica per i Benedettini perché erano posti a guardia dei varchi di accesso alla Val di Comino che era la zona più fertile dei domini dell’Abbazia. Per questo motivo risulta interessante la sua storia nella cornice dell’organizzazione territoriale benedettina. Il suo nome deriva dal nome del martire e santo Magno di Anagni. Il centro storico è per lo più medievale, circondato da mura imponenti volute dai signori di Aquino, e si sviluppa intorno alla torre dell’antico palazzo, edificata nel XIII secolo e ristrutturata dopo il terremoto del 1984.
Se venite a Colle san Magno il lunedì di Pasqua potete unirvi ai fedeli che salgono sul Monte Asprano e raggiungono la chiesetta dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo, un santuario mariano costruito nel 1300. Qui i cittadini di Colle San Magno si incontrano con i fedeli che arrivano da Castrocielo e tutti assieme assistono al famoso “bacio delle due Madonne” che ciascun gruppo porta con sé .
Sulla stessa sommità, a 750 metri, di altezza, si possono visitare i resti del Castello di Castrum Coeli che fu il primo rifugio che gli abitanti di Castrocielo trovarono per sfuggire alle scorrerie dei Longobardi, dei Saraceni e dei Normanni, nella valle.
2.a Tappa: Colle San Magno - Roccasecca
Prima di scendere a Roccasecca lungo i tornanti del monte è importante visitare il Castello di Roccasecca e la chiesetta dedicata a San Tommaso d’Aquino.
Il Castello fu costruito nel 994 sul monte Asprano per volere dell’abate di Montecassino Masone, alleandosi con la famiglia dei D’Aquino di Pontecorvo. I primi “signori” aquinati erano longobardi e diedero origine alla dinastia e alla Contea di Aquino che terminò dopo la vittoria dei Normanni e di Riccardo II nell’Italia meridionale. Il castello aveva uno scopo difensivo perché consentiva il controllo della bassa valle del Liri. Fu distrutto e costruito più volte. Si racconta che San Tommaso nacque in questo castello. Nonostante sia ridotto in ruderi, il castello è costituito dai resti di una cinta muraria a pianta quadrangolare munita ai vertici Nord -Est e Nord-Ovest di torri e con un mastio e una torre nell’angolo Sud-Est. All’esterno delle mura si trova la torre di avvistamento detta del “cannone”. Secondo la tradizione qui fu rinchiuso San Tommaso dalla famiglia che osteggiava la sua scelta religiosa dopo il primo periodo di prigionia a San Giovanni Campano. Sotto il Mastio e la torre cilindrica si trova la chiesetta di Santa Croce fuori le mura, costruita dai Conti di Aquino, dove certamente Tommaso d’Aquino è stato a pregare. Sotto la rupe dominata dal castello c’è poi la Chiesa di San Tommaso costruita in onore di San Tommaso d’Aquino, tra il 1323 e il 1325. La chiesa affiancata da un campanile accoglie al suo interno diversi affreschi del quindicesimo secolo.
Il Castello fu costruito nel 994 sul monte Asprano per volere dell’abate di Montecassino Masone, alleandosi con la famiglia dei D’Aquino di Pontecorvo. I primi “signori” aquinati erano longobardi e diedero origine alla dinastia e alla Contea di Aquino che terminò dopo la vittoria dei Normanni e di Riccardo II nell’Italia meridionale. Il castello aveva uno scopo difensivo perché consentiva il controllo della bassa valle del Liri. Fu distrutto e costruito più volte. Si racconta che San Tommaso nacque in questo castello. Nonostante sia ridotto in ruderi, il castello è costituito dai resti di una cinta muraria a pianta quadrangolare munita ai vertici Nord -Est e Nord-Ovest di torri e con un mastio e una torre nell’angolo Sud-Est. All’esterno delle mura si trova la torre di avvistamento detta del “cannone”. Secondo la tradizione qui fu rinchiuso San Tommaso dalla famiglia che osteggiava la sua scelta religiosa dopo il primo periodo di prigionia a San Giovanni Campano. Sotto il Mastio e la torre cilindrica si trova la chiesetta di Santa Croce fuori le mura, costruita dai Conti di Aquino, dove certamente Tommaso d’Aquino è stato a pregare. Sotto la rupe dominata dal castello c’è poi la Chiesa di San Tommaso costruita in onore di San Tommaso d’Aquino, tra il 1323 e il 1325. La chiesa affiancata da un campanile accoglie al suo interno diversi affreschi del quindicesimo secolo.
3.a. Tappa: Roccasecca – Castrocielo - Aquino
Se ci si ferma a Roccasecca si può visitare il borgo medievale del “Castello” . Per accedere al cortile si attraversa un monumentale arco a sesto acuto al di sopra del quale è posta un’epigrafe a cui si deve la denominazione tradizionale di Casa di San Tommaso, forse riferito ad un personaggio omonimo.
Poi si prende la strada per Castrocielo e ci si deve necessariamente soffermare nel borgo medievale di Caprile e fare una deviazione per visitare l’eremo di San Michele
Scendendo poi verso la Via Latina si giunge ad Aquino. Aquino viene conquistato dai longobardi sotto il comando del Duca di Benevento, Zottone, verso il 587/589. Nell’anno mille il Castello di Aquino era difeso da mura e circondato dalle acque. Il prosciugamento delle acque e alla bonifica dell’area ha portato alla luce quello che ora viene chiamato il Vallone, un’area verse attrezzata per lo sport all’area aperta. Il borgo medievale conserva la torre quadrata che si erge vicino alla casa di San Tommaso, ora destinata a museo. Si deve ad Adenolfo II la costruzione della residenza comitale fortificata sullo scoglio di travertino che oggi costituisce il borgo medievale di Aquino. Anche in questa occasione si possono scoprire i rapporti non sempre tranquilli tra i Conti di Aquino e l’Abbazia. Nel 953 Atenolfo II riesce addirittura a imprigionare l’abate Aligerno conducendolo ad Aquino e sottoponendolo a pubblica umiliazione.
Ricordiamo che qui, intorno al 1225 nasce Tommaso d’Aquino, figlio di Landolfo, unico erede dei feudi della media valle del Liri e Teodora, la sua seconda moglie.
Poi si prende la strada per Castrocielo e ci si deve necessariamente soffermare nel borgo medievale di Caprile e fare una deviazione per visitare l’eremo di San Michele
Scendendo poi verso la Via Latina si giunge ad Aquino. Aquino viene conquistato dai longobardi sotto il comando del Duca di Benevento, Zottone, verso il 587/589. Nell’anno mille il Castello di Aquino era difeso da mura e circondato dalle acque. Il prosciugamento delle acque e alla bonifica dell’area ha portato alla luce quello che ora viene chiamato il Vallone, un’area verse attrezzata per lo sport all’area aperta. Il borgo medievale conserva la torre quadrata che si erge vicino alla casa di San Tommaso, ora destinata a museo. Si deve ad Adenolfo II la costruzione della residenza comitale fortificata sullo scoglio di travertino che oggi costituisce il borgo medievale di Aquino. Anche in questa occasione si possono scoprire i rapporti non sempre tranquilli tra i Conti di Aquino e l’Abbazia. Nel 953 Atenolfo II riesce addirittura a imprigionare l’abate Aligerno conducendolo ad Aquino e sottoponendolo a pubblica umiliazione.
Ricordiamo che qui, intorno al 1225 nasce Tommaso d’Aquino, figlio di Landolfo, unico erede dei feudi della media valle del Liri e Teodora, la sua seconda moglie.
4.a Tappa: Aquino – Piedimonte alta
Da Aquino la strada porta a Piedimonte San Germano, la cui parte bassa si distende intorno alla Via Casilina. Da una parte ci sono le abitazioni e dall’altra c’è l’insediamento Fiat. Una scalinata porta al Castello dei Conti di Aquino. Anche qui Adenolfo II ha operato concretamente. Il luogo è certamente strategico perché riesce a dominare tutta la valle del Liri e per questo motivo è stato utilizzato dagli Ausoni, poi dai Volsci, i Sanniti i Romani e i barbari e saccheggiato dai Saraceni. Adenolfo II, nel 1061 lo fece ricostruire dotandolo di una più ampia cinta muraria, per cui dal X sec. d.C. esso divenne la roccaforte della Terra di San Benedetto. Purtroppo, il Castello ha subito pesanti bombardamenti durante la seconda Guerra mondiale ed è stato ristrutturato nel 2001.
5.a Tappa: Piedimonte alta - Rocca Janula
Se si ridiscende a valle e si segue il percorso che fa la Via Francigena nel Sud, imboccando la Via di Santa Scolastica, si arriva davanti al Museo nazionale G. Carettoni di Cassino e scendendo verso Cassino si passa proprio davanti al cancello del Castello di Rocca Janula.
Anche questo castello è opera dell’abate Aligerno. Esso si trova a 187 metri s.l.m., a mezza strada tra Cassino e Montecassino, che si trova a 516 metri s.l.m. Esso fu costruito per difendere il monastero e pertanto aveva una espressa vocazione militare, anche se poteva ospitare fino a 2.000 persone in caso di necessità. L’abate Gerardo intervenne a a potenziare il castello dopo il terremoto del 1004 e gli Abati Roffredo e Atenolfo continuarono l’opera di fortificazione nel secolo successivo. La storia del castello è lunga perché è sempre stata o temuta o usata. Purtroppo i bombardamenti degli Alleati nelle quattro battaglie di Montecassino lo hanno fortemente danneggiato lasciando in piedi solo la torre pentagonale e le mura perimetrali e gli difici interni. Le opere di recupero hanno consentito la sua riapertura dal 25 settembre del 2015.
Anche questo castello è opera dell’abate Aligerno. Esso si trova a 187 metri s.l.m., a mezza strada tra Cassino e Montecassino, che si trova a 516 metri s.l.m. Esso fu costruito per difendere il monastero e pertanto aveva una espressa vocazione militare, anche se poteva ospitare fino a 2.000 persone in caso di necessità. L’abate Gerardo intervenne a a potenziare il castello dopo il terremoto del 1004 e gli Abati Roffredo e Atenolfo continuarono l’opera di fortificazione nel secolo successivo. La storia del castello è lunga perché è sempre stata o temuta o usata. Purtroppo i bombardamenti degli Alleati nelle quattro battaglie di Montecassino lo hanno fortemente danneggiato lasciando in piedi solo la torre pentagonale e le mura perimetrali e gli difici interni. Le opere di recupero hanno consentito la sua riapertura dal 25 settembre del 2015.
6.a. Tappa: Rocca Janula – San Vittore del Lazio
Dal Castello si può scendere a Cassino e prendere la Casilina in direzione Venafro fino allo svincolo per San Vittore del Lazio, oppure si può seguire il tracciato collinare della Francigena nel Sud e salire quindi a Cervaro e proseguire fino a San Vittore del Lazio. Sul territorio di Cervaro si può riscendere per andare a visitare il Castello di Torrocolo posto sul monte Trocchio. Il Castello è stato costruito nel 1057 e si mantiene ancora bene nonostante i terremoti, la peste del ‘600 e i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale. Nella zona ci sono diverse grotte interessanti in una delle quali, denominata “dell’eremita”, sembra sia stata usata anche da San Benedetto. Naturalmente anch’esso è stato costruito dai benedettini per controllare la valle e i movimenti di chiunque l’attraversasse.
San Vittore è abbastanza vicino a Cervaro a circa 220 s.l.m. ed è una piccola cittadella fortificata. Il perimetro della cittadella è costituito da torri quasi tutte quadrangolari e da mure lunghe un chilometro e mezzo. In origine ce n’erano ventitré, ora ne sono rimaste poche, anche perché anche San Vittore ha subito le conseguenze delle battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Le mura sono comunque ben conservate e il borgo interno rende proprio l’idea di essere dentro una cittadella medievale. Anche questa realtà è opera dei benedettini provenienti dall’Abbazia che la realizzarono nella prima metà dell’XI secolo d.C. secondo la logica del “Castrum”
San Vittore è abbastanza vicino a Cervaro a circa 220 s.l.m. ed è una piccola cittadella fortificata. Il perimetro della cittadella è costituito da torri quasi tutte quadrangolari e da mure lunghe un chilometro e mezzo. In origine ce n’erano ventitré, ora ne sono rimaste poche, anche perché anche San Vittore ha subito le conseguenze delle battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Le mura sono comunque ben conservate e il borgo interno rende proprio l’idea di essere dentro una cittadella medievale. Anche questa realtà è opera dei benedettini provenienti dall’Abbazia che la realizzarono nella prima metà dell’XI secolo d.C. secondo la logica del “Castrum”
Tappe alternative
Alternativa di percorso
1.a Tappa: San Vittore del Lazio - Cassino- Rocca Janula
2.a. Tappa: Rocca Janula – Piedimonte San Germano alta
3.a. Tappa: Piedimonte alta – Terelle
4. Tappa: Terelle – Colle San Magno
5,a Tappa: Colle San Magno – Roccasecca
6.a. Tappa: Roccasecca – Castrocielo - Aquino
7.a. Tappa: Aquino – Cassino
1.a Tappa: San Vittore del Lazio - Cassino- Rocca Janula
2.a. Tappa: Rocca Janula – Piedimonte San Germano alta
3.a. Tappa: Piedimonte alta – Terelle
4. Tappa: Terelle – Colle San Magno
5,a Tappa: Colle San Magno – Roccasecca
6.a. Tappa: Roccasecca – Castrocielo - Aquino
7.a. Tappa: Aquino – Cassino
Il Castello di Esperia
Se da Aquino vi allungate verso ovest potete visitare il Castello Medievale di Esperia. Esso fu costruito intorno al 1103, su probabili preesistenze più antiche, dal cavaliere normanno Guglielmo di Glossavilla (Bloseville), il quale concentrò la popolazione nell'abitato, che prese il nome di Roccaguglielma, posto ai piedi della rocca e lo difese con una cerchia di mura. Il castello, per la sua posizione strategicamente importante, era funzionale al controllo dell'importante passo montano che congiungeva direttamente i possedimenti normanni di Pontecorvo ed Aquino con Gaeta, senza passare per Cassino. Roccaguglielma con: Pico, San Giovanni Incarico, Campello e Rivomatrice, formò una specie di stato indipendente, denominato dei "cinque Castelli de Foris", perché erano fuori dei possedimenti dell'Abbazia di Montecassino. Il castello in rudere è visitabile gratuitamente.
Il Castello di Castelnuovo Parano
Dalla parte opposta di Esperia trovate Castelnuovo Parano e trovato un altro Castello.
Il Castello sorto tra il 1050 e il 1060 dà il nome al grazioso paese che sorge sul Monte Parano. Nel corso del tempo all’ombra del Castello si formarono i vari Casali, alcuni dei quali presero nome da famiglie illustri dell’epoca. Nel XVII secolo, gran parte degl’abitanti emigrò a Napoli per lavorare come facchini alla Dogana. Nel 1656 la peste decimò la popolazione, che vantava di dottori e avvocati. Nel 1806, in seguito alle riforme Napoleoniche, Castelnuovo dipese dal Governo centrale napoletano e dopo nel 1870 entrò a far parte della provincia di Caserta, solo dopo, nel 1927 della provincia di Frosinone.
Il paese subì molti danni perché fu teatro dei combattimenti fra alleati lungo la linea “Gustav” nella seconda guerra mondiale. Testimonianza di ciò sono i resti del Castello che si trovano nell’antico borgo e quelli di alcuni rifugi presenti nella campagna del paese. Posto in posizione favorevole, il Castello sorto tra il 1050 e il 1060 da il nome al grazioso paese che sorge sul Monte Parano. Nel corso del tempo all’ombra del Castello si formarono i vari Casali, alcuni dei quali presero nome da famiglie illustri dell’epoca.
Nel XVII secolo, gran parte degl’abitanti emigrò a Napoli per lavorare come facchini alla Dogana. Nel 1656 la peste decimò la popolazione, che vantava di dottori e avvocati. Nel 1806, in seguito alle riforme Napoleoniche, Castelnuovo dipese dal Governo centrale napoletano e dopo nel 1870 entrò a far parte della provincia di Caserta, solo dopo, nel 1927 della provincia di Frosinone.
Il paese subì molti danni perché fu teatro dei combattimenti fra alleati lungo la linea “Gustav” nella seconda guerra mondiale. Testimonianza di ciò sono i resti del Castello che si trovano nell’antico borgo e quelli di alcuni rifugi presenti nella campagna del paese.